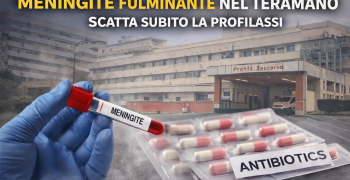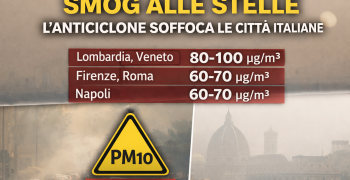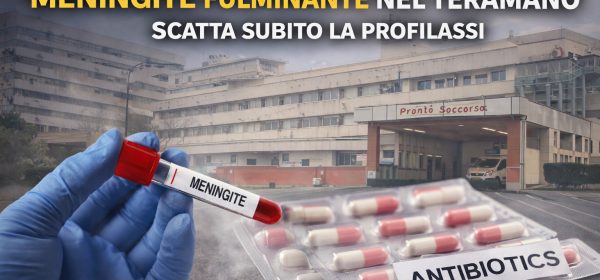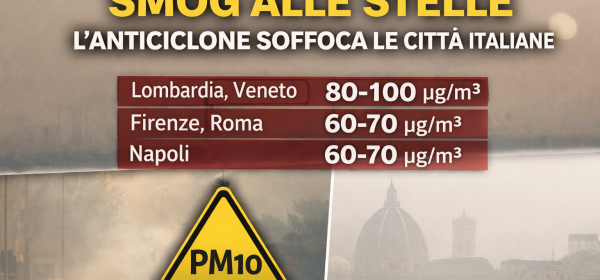L'Aquila / Terremoto 6 aprile 2009 sulla Specola Inaf dell'Osservatorio Astronomico "V. Cerulli" di Collurania: cos'è successo alle ore 3:32 a Teramo? L'attività scientifica non si è mai fermata. I segreti del Sole, dell'Universo, dei terremoti e dei 430 esopianeti finora scoperti su 363 stelle, in attesa del primo vero mondo extraterrestre abitato. La vita su Marte, Europa e Titano? Rivoluzione copernicana imminente: l'espansione del concetto di "mondo abitabile". La vita attecchisce ovunque! I numeri elaborati da Isaac Asimov sui sistemi solari simili al nostro e sull'ammontare delle civiltà extraterrestri nella Galassia, vanno sicuramente corretti al rialzo! Ecco la più accurata mappa 3D dell'Universo, immortalata dal telescopio spaziale Hubble. Oltre a confermare la Teoria Generale della Relatività, l'espansione accelerata dell'Universo, le abbondanze di Materia ed Energia oscure, il team internazionale Nasa/Esa guidato dai professori P. Simon (Università di Bonn) e T. Schrabback (Leiden Observatory), grazie alle micro lenti gravitazionali (il più potente obiettivo naturale del Cosmo, magari utile per "zoommare" su un esopianeta ET abitato!) sono riusciti per la prima volta in assoluto a sondare le profondità del Creato nel più ambizioso progetto di esplorazione e studio di 446 mila galassie. Utile a cosa? A svelare le strutture più intime dell'Universo nello spazio e nel tempo, anche se ancora non è del tutto chiaro ciò che si sta e non si sta osservando. A ulteriore conferma che bisogna prima interrogare Colui che ha fatto il mondo, con le domande e gli esperimenti giusti, prima di contemplare correttamente il divino disegno del Creato. C'est l'Antartique! In diretta dalla Base Concordia: progressi nel progetto antartico del Telescopio Irait, breve bilancio della campagna estiva 2009-10. Gli astronomi Inaf di Collurania e Perugia stanno donando la vista al telescopio infrarosso nel cuore dell'Antartide. L'Osservatorio di Teramo partecipa al progetto Arena, un network internazionale finanziato dalla Comunità Europea. Il messaggio dell'Ambasciatore italiano in Nuova Zelanda, Gioacchino Trizzino, ospite del Programma Nazionale Ricerche Antartide: è epocale "la capacità dei Paesi della Terra di cooperare pacificamente in questo eccezionale, sconfinato ed unico laboratorio naturale per l'ampliamento delle conoscenze umane e per il bene dell'intera umanità".
C'est l'Antartique! Il 6 febbraio 2010 è terminata la XXV campagna estiva alla base italo-francese Concordia ed il 7 febbraio è iniziata la sesta campagna invernale alla quale partecipano 14 persone. La spedizione estiva era iniziata il 17 novembre 2009. Dopo il transito dalla base italiana di Baia Terra Nuova e quella francese di Dumont D'Urville, gli scienziati hanno raggiunto la stazione scientifica di Concordia a "Dome C" collocata a 75° sud. Qui il telescopio infrarosso "Irait", frutto di una collaborazione scientifica internazionale che vede la Specola Inaf di Collurania tra le protagoniste indiscusse dell'impresa insieme all'Università di Perugia, è stato oggetto del naturale processo di montaggio iniziato lo scorso anno con l'installazione della struttura meccanica e della parte elettronica.
Quest'anno il programma prevedeva il montaggio degli specchi, della camera e del software, tra le officine della base Concordia, il "campo estivo" e il sito astronomico del telescopio. "Le persone impegnate in questa missione sono due inviati dell'Università di Perugia, ente leader del progetto, e uno dall'Osservatorio di Teramo, coadiuvati dall'aiuto di due scienziati francesi e della logistica della base" - fa notare Alberto Mancini dell'Università di Perugia. Il 17 febbraio 2010 alle ore 12.15 (24.15 ora italiana) la nave Italica è arrivata al porto di Lyttelton (Nuova Zelanda): a bordo gli 81 partecipanti alla spedizione e i 28 membri dell'equipaggio. Il lavoro da fare in Antartide è tantissimo anche d'inverno, quando in Italia è primavera-estate.
"Si costruiscono ripari per le macchine che dovranno lavorare per tutto l'inverno, nuovi laboratori di ricerca che permetteranno attività scientifiche per tutto l'anno. La stazione è un vero cantiere e tutto deve essere terminato prima dell'arrivo dell'inverno" - rivela Boris Padovan, classe 1975, laureato in Astronomia a Padova, PhD in Scienze Spaziali tra università di Padova e di Austin, Texas.
Da quattro anni lavorava a Padova come consulente informatico, poi ecco l'opportunità di fare il winter-over a Concordia 2010 come tecnico informatico esperto di telecomunicazioni. Durante il lungo inverno antartico seguirà il corretto funzionamento di quattro esperimenti scientifici: Domex, consistente di un radiometro che osserva dall'alto il ghiaccio entro una certa banda di frequenza; Saoz, che studia il contenuto di ozono nell'aria; Geoelectric field, atto a misurare di continuo il campo elettrico della Terra; Hamstrad, per le misure nella banda delle microonde di temperatura e umidità dell'aria. Ed annessi progetti di ricerca astronomica. Insieme a Karim Agabi dottore in "Sciences et Images de l'Universe"(Università di Nizza Sophia-Antipolis,1994), ingegnere elettronico (Ecole Nationale Polytechnique d'Algeria, 1989). Attualmente Ingegnere di ricerca e strumentazione scientifica per l'osservazione astrofisica presso il laboratorio Fizeau, Università di Nizza Sophia-Antipolis.
Dal 1999 è capo-progetto del programma Astroconcordia. Dopo la sua prima missione a Dome C, nel 2000 ha partecipato a tutte le campagne estive e alla prima stagione invernale (2004-2005) presso la base Concordia. L'obiettivo in materia di astronomia era, all'epoca, di studiare le caratteristiche del luogo e di effettuare le prime misure di stabilità dell'atmosfera per le osservazioni astronomiche. "L'esperienza acquisita e il mio livello di conoscenza sul funzionamento degli strumenti in condizioni estreme (fino a -78°C), mi hanno permesso di essere parte autorevole nel progetto ASTEP (Antartic Search for Transiting ExoPlanets).
Quattro anni di messa a punto del telescopio ASTEP, insieme ad un'equipe molto motivata, e le responsabilità della mia posizione di capo progetto, mi hanno spinto a lanciarmi in un secondo inverno a Concordia. Eccomi, dunque, pronto a vivere una nuova avventura umana e scientifica fuori dalla norma, in questo deserto di ghiaccio". Concordia sul plateau a 1200 km dalla costa, dove le temperatura giornaliera oscilla tra -40° e -30°C, offre opportunità uniche per la ricerca scientifica. Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e l'Istituto Polare Francese (IPEV) firmarono nel 1993 un accordo di cooperazione per la costruzione della stazione Concordia nella località di Dome C, aperta dal 2005 alla comunità scientifica internazionale. Un sito vantaggioso. Il Comitato Scientifico sulla Ricerca in Antartide (SCAR) ha anche pubblicato un interessante Report sui cambiamenti climatici dal titolo:"Antarctic Climate Change and the Environment" e una serie di studi sulla capacità della vita di attecchire ovunque, anche negli ambienti più estremi. Da queste parti si dice: c'est l'Antartique! Come a dire che contro la natura, quando ci si mette, è bene accettarla invece di volerla dominare. Questa battuta è tremendamente vera e i nostri ricercatori la sperimentano sulla propria pelle ogni giorno.
Chi viene a Concordia lo fa per lavoro e per passione, con l'intento di dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia e tra mille difficoltà, alla ricerca scientifica. Anche se per i media italiani il loro grande lavoro, sembra poca cosa! E in cambio cosa ci insegnano i nostri scienziati? Come lavorano la scienza e la tecnologia: con grande umiltà in un ambiente lontano dall'Italia accogliente dei climi temperati, e talmente ostile che finora non è mai stato abitato. Un'anticipazione delle esperienze che vivranno i futuri esploratori dello spazio cosmico, come prefigurato dal kolossal Avatar di James Cameron che ha reso plausibile il primo volo interstellare su Alpha Centauri, sulla ISV Venture Star, a centinaia di milioni di persone. Che hanno assicurato il biglietto per il primo volo di Cameron nello spazio suborbitale grazie alla navicella privata VSS Enterprise della Virgin Galactic.
A conclusione della campagna estiva, l'Ambasciatore italiano in Nuova Zelanda, Gioacchino Trizzino, ospite in Antartide del PNRA presso la Stazione Mario Zucchelli, ha dichiarato nel saluto pervenuto al Direttore Generale del Programma Nazionale Ricerche Antartide (Ing. A. Cucinotta): "Nel momento in cui l'Italica, dopo l'ultima traversata antartica, si appresta ad attraccare nuovamente nel porto di Littelton per intraprendere poi la via del ritorno in Italia, desidero esprimerLe i sensi della mia profonda gratitudine per avermi dato l'occasione di vivere un'esperienza straordinaria accanto ad uomini di cui il nostro Paese può essere giustamente orgoglioso per la profonda fede che hanno nella loro missione ed il grande entusiasmo con cui la portano avanti; per il forte impegno che dispiegano nella loro attività e la costante tenacia con cui lottano quotidianamente contro le avversità di una natura affascinante ma anche estremamente difficile; per l'acuta intelligenza e l'innata curiosità che li accompagnano nella ricerca dei grandi segreti che nasconde l'immenso e misterioso Continente Bianco. Il mio sentito apprezzamento va a tutti indistintamente: dirigenti, ricercatori, specialisti in logistica, tecnici, operatori a tutti i livelli ed anche, naturalmente, all'equipaggio ed al Capitano dell'Italica, perché tutti portano con onore la bandiera dell'Italia agli estremi confini del mondo. E va soprattutto a Lei, caro Direttore Generale, che guida con tanta capacità e chiarezza di visione questo piccolo esercito di specialisti affinché rechino il contributo dell'Italia nel continente dedicato alla pace ed alla scienza. La mia esperienza è stata straordinaria - prosegue Gioacchino Trizzino - non solo perché straordinario è il mondo che ho visitato ma anche perché straordinari sono gli uomini che vi lavorano e straordinario è il lavoro che portano avanti.
L'Antartide è un continente al quale appena ci affacciamo e la sfida che pone a noi ed al mondo intero è epocale: la capacità dei Paesi della Terra di cooperare pacificamente in questo eccezionale, sconfinato ed unico laboratorio naturale per l'ampliamento delle conoscenze umane e per il bene dell'intera umanità. L'Italia è stata lungimirante e generosa nel creare le sue basi in Antartide. Momenti difficili non hanno poi mancato di riflettersi negativamente sui vasti e vari programmi di ricerca intrapresi. Ma la fiducia ci anima. I momenti difficili saranno presto alle nostre spalle e la nostra azione nel Continente di ghiaccio riprenderà con lo stesso ed anche con maggior vigore di prima. La nostra fede nel progresso umano non deve tradirci, così come non deve tradirci il coraggio che è sempre l'essenza delle grandi imprese. E l'azione, che è il concretizzarsi di entrambi, dovrà essere alla loro altezza. La presenza dell'Italia in Antartide è una grande impresa che può e deve continuare ed anche accrescersi perché la ricerca è la base dello sviluppo e perché in quel continente dobbiamo proseguire assieme agli altri popoli per l'affermazione di una via nuova verso la cooperazione internazionale e la pace. La fiducia, il coraggio e l'azione devono essere di ognuno di noi e di tutti assieme.
Mi permetto di parlare di noi, e non solo di voi, perché l'esperienza che ho vissuto in pochi giorni ha conquistato il mio cuore e la mia mente e mi ha fatto capire, ancora più di prima, come tutti assieme dobbiamo combattere questa battaglia comune. Nell'Italica ed in quei ghiacci eterni mi sono sentito uno di voi e voglio essere uno di voi. Nel mio piccolo, non mancherò di fare la mia parte, sicuro che anche voi continuerete a lottare per questi ideali comuni. La vostra battaglia sarà la mia. Quale rappresentante dell'Italia in Nuova Zelanda, do' il benvenuto in questa terra a tutti coloro che ora vi giungono a bordo dell'Italica, italiani ed altri cittadini del mondo che lottate per la scienza e per la pace, e ringrazio voi tutti e Lei in primis, caro Ing. Cucinotta, per quello che avete fatto e per quello che continuerete a fare per il nostro Paese e per il progresso dell'umanità".
A Teramo, l'Osservatorio Astronomico "V. Cerulli" di Collurania, sta facendo la sua parte. Nell'impresa antartica e non solo. Dopo aver subito il tremendo scossone del sisma aquilano del 6 aprile 2009, nonostante le "ferite" inferte dalla Natura siano state ingenti ed ancora vive nei ricordi e nei cuori di tutti, le ricerche non si sono mai interrotte. Il museo, la biblioteca, la cupola saranno restituiti alla comunità scientifica in totale sicurezza. Tanti i progetti in cantiere. Lunedì 22 febbraio 2010 al Liceo Classico "M. Delfico", 21 ragazzi provenienti da Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, hanno partecipato alla Gara interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2010, per le categorie "Junior" (10 candidati) e "Senior" (11 candidati). Test che si svolgono ogni anno come consuetudine a Teramo grazie ai ricercatori di Collurania, una delle 12 specole italiane dell'Istituto nazionale di astrofisica. Qui gli studi si concentrano sulle ricerche teoriche ed osservative dell'evoluzione stellare, con particolare riferimento alle fasi evolutive avanzate e finali.
La mappa, in termini di età e di altri parametri fisici, dei sistemi stellari della nostra e di altre galassie, viene tracciata al fine di ricostruire la storia evolutiva dell'Universo. Importanti risultati sono stati ottenuti nella datazione degli ammassi stellari dell'alone e del disco galattico, che hanno permesso di collocare nel tempo la formazione delle varie componenti della Via Lattea. Da questa ricostruzione della storia evolutiva della Via Lattea (http://www.nasa.gov/externalflash/mather/) si è capito che le stelle più vecchie hanno un'età compresa tra i 13 e i 14 miliardi d'anni. Valore che permette di determinare con precisione l'epoca di formazione delle galassie, avvenuta solo poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Il raggiungimento di questi risultati presuppone una dettagliata conoscenza delle leggi fisiche che governano il comportamento della materia nelle stelle: i ricercatori Inaf dell'osservatorio astronomico di Collurania partecipano a collaborazioni internazionali rivolte allo studio di questi processi elementari, come le misure dell'efficienza delle reazioni nucleari di fusione che generano le energie responsabili della luminosità stellare.
Un impegno particolare è stato speso nello studio delle supernovae, violente esplosioni di stelle causate dal collasso gravitazionale del nucleo o dall'innesco di reazioni termonucleari non contro-reazionate: queste ricerche hanno lo scopo di comprendere la natura dei processi fisici che controllano tali esplosioni-implosioni stellari. Gli astronomi sono in attesa di un tale evento nella nostra Galassia ormai da 400 anni, dalla nascita della scienza moderna ad opera di Galileo Galilei. In tal caso le notti potrebbero brillare davvero per mesi. Senza contare i rivelatori di neutrini sotto il Gran Sasso che, insieme agli scienziati, potrebbero impazzire di gioia, magari con saturazione di segnale! Le supernovae, grazie alla loro enorme brillanza, sono visibili anche a grandi distanze e possono informarci sullo stato dell'Universo lontano nello spazio ma anche lontano nel tempo, se si considera il fatto che la luce da loro emessa può viaggiare per miliardi di anni prima di essere rivelata dai nostri strumenti. Tra i risultati più importanti collegati all'uso delle supernovae come traccianti della storia cosmica, va ricordata la recente scoperta che l'espansione dell'Universo procede oggi più velocemente di quanto non accadesse un paio di miliardi d'anni fa.
L'Universo sta accelerando: le implicazioni di questa scoperta sono oggetto dei più importanti studi nel campo della fisica fondamentale. La gravità che si pensava fosse la forza dominante a grandi distanze, è attrattiva e, per questo, dovrebbe provocare una decelerazione dell'espansione. In altre parole, gli studi delle supernovae lontanissime (ad alto redshift, come dicono gli astrofisici) hanno rivelato l'esistenza di una forma di Energia Oscura, ossia non ancora conosciuta, in grado di opporsi alla forza gravitazionale, fino ad accelerare l'espansione delle galassie e di tutti noi. Con finalità analoghe, all'osservatorio di Teramo vengono studiati diversi tipi di variabilità stellare, dalle RR-Lyrae alle Cefeidi. Queste stelle sono ottimi indicatori di distanza e ci permettono di valutare le dimensioni dell'Universo locale, le ricerche sulla sintesi delle popolazioni stellari estendono la nostra conoscenza dell'Universo locale verso le galassie più lontane. La ricerca sulla sintesi della materia completa l'indagine del cosmo ed è volta alla comprensione dei processi che presiedono all'evoluzione chimica delle galassie.
Rilevante a Collurania è l'attività di tipo tecnologico, caratterizzata dallo sviluppo di strumentazione innovativa da utilizzare per questi studi. Il progetto Swirt è frutto di una collaborazione Teramo-Roma-Pulkovo e ha permesso l'istallazione di un telescopio da 1,1 metri a Campo Imperatore dotato di una camera per osservazioni di luce infrarossa. La camera è stata finanziata dalla Regione Abruzzo all'osservatorio di Teramo, e per anni è stata l'unica camera infrarossa operante sul territorio nazionale. Le ricerche, sono finalizzate all'inseguimento di supernovae vicine e ad altri studi di variabilità stellare, stanno producendo risultati di altissima valenza che hanno aperto la strada a collaborazioni internazionali più ampie, anche nell'ambito di un key project approvato dal board del Telescopio spaziale Hubble.
Di una certa rilevanza è la partecipazione scientifica di Collurania ai progetti Luna ed Erna dell'Infn per la misura di sezioni d'urto nucleari di interesse astrofisico. L'osservatorio Inaf di Teramo contribuisce alla programmazione degli esperimenti e guida la valutazione dell'impatto astrofisico delle misure. Senza contare la partecipazione al progetto "Calcolo evoluto e sue applicazioni Rvs6" attuato dal Consorzio di Ricerca del Gran Sasso per il Miur, con l'installazione di una mini farm di calcolo per il trattamento di immagini presso l'Osservatorio che presto sarà la sede di un nodo della rete Grid nazionale per il calcolo distribuito e del progetto di Virtual Observatory, nato per consentire l'accesso ai maggiori archivi di dati astronomici mondiali. Il progetto antartico della Specola di Collurania è l'Infrared Robotic Antartic International Telescope, che vede l'osservatorio di Teramo partecipare al Consorzio internazionale per la realizzazione della strumentazione di piano focale (camera AMICA, Antarctic Multiband Infrared CAmera). Il progetto prevede la costruzione di un telescopio robotico nella base italo-francese Concordia, situata nel cuore del continente Antartico, precisamente a "Dome C" (3233 mt. di quota, 75° Sud e 123° Est), a 1500 km dalla base italiana Terranova, per promuovere lo sviluppo dell'astronomia infrarossa. L'Osservatorio di Collurania partecipa al progetto Arena, un network internazionale finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del VI programma quadro (FP6).
Forse pochi sanno cos'è successo alla Specola di Collurania quel 6 aprile 2009 nelle ore immediatamente successive alle 3:32. La più danneggiata per l'attività lavorativa degli astronomi Inaf di Collurania, nonché per l'affetto culturale e storico, è stata la palazzina originale dell'osservatorio di Teramo, fatta costruire da Vincenzo Cerulli alla fine del XIX Secolo. I danni strutturali, evidenti. La Protezione civile ha dichiarato inagibile l'edificio immediatamente dopo il sisma del 6 aprile. Danni ai solai e ai muri portanti, dovuti sia alle tecniche costruttive dell'epoca sia agli interventi di restyling effettuati nel XX Secolo.
Le scale interne dopo gli anni Trenta furono ristrutturate con tecniche più moderne e gravano su pareti portanti originali: sono un corpo rigido soggetto ad oscillazioni disomogenee, battuto dal sisma sulle pareti. Le scale hanno amplificato gli effetti. Così lo stesso pilastro su cui è montato il telescopio "Cooke" del Cerulli, separato dalla cupola e dall'edificio stesso, ha subito delle oscillazioni così ampie da sbattere sui solai e sulle pareti portanti ad essi collegate, danneggiandoli. E poi il "ponte" di cemento che lega i due edifici principali dell'osservatorio con la palazzina degli uffici più moderna: la struttura rigida della cupola ha fatto da martello su tutte le pareti perpendicolari. I ricercatori Inaf sono intervenuti rapidamente con somma urgenza, spostando risorse già impegnate per un intervento di manutenzione sulla cupola. L'osservatorio è stato ingabbiato, consolidando la struttura con un intervento di messa in sicurezza per evitare ulteriori crolli dovuti alle scosse. Assicurano che l'Oact è in sicurezza. Architravi, pareti e solai danneggiati sono stati puntellati con manufatti in legno e ferro che garantiscono la sicurezza.
Adesso bisogna provvedere al ripristino dell'osservatorio alla situazione precedente al sisma del 6 aprile, migliorando la sicurezza anti-sismica dell'osservatorio, qualora dovessero ripetersi eventi simili in futuro. Poiché viviamo in una zona soggetta a questi fenomeni e l'astronomo Cerulli lo sapeva. Pochi sanno che quel 6 aprile 2009 è stato danneggiato quasi il 50% della Specola. Fortunatamente però tutti gli uffici erano nella palazzina del Direttore che ha subito danni minori. Oltre la cupola, sono stati danneggiati il museo, la biblioteca. E, a piano terra, i laboratori che subito dopo il sisma sono stati spostati: così l'attività scientifica non si è mai fermata. In una settimana dal sisma i Nostri sono diventati nuovamente operativi. Grazie al lavoro di tutto il personale che si è prodigato efficacemente anche nel trasporto di materiali ed attrezzature. Hanno trovato altri spazi temporanei di fortuna che hanno permesso di continuare a lavorare sulla camera antartica "Amica" del telescopio infrarosso Irait.
Grazie al lavoro di tutti i dipendenti dell'osservatorio, è stato ricreato il laboratorio per l'assemblaggio della camera, alla base del telescopio T.N.T. di Collurania. Se la vista infrarossa al telescopio antartico Irait è una realtà, lo dobbiamo ai ricercatori di Collurania. Lo scorso anno è cominciato il montaggio della struttura portante del telescopio Irait, con i servo-motori, la sezione meccanica, la forcella, il corpo centrale dello strumento, tutti antarticizzati. La cupola è stata aperta e chiusa da remoto, i servo-meccanismi funzionano. Il programma prevede di montare le ottiche del telescopio: si tratta di specchi molto complessi. Il secondario è basculante: progettato per catturare immagini con 10-20 oscillazioni al secondo. Come lavora il telescopio Irait per l'astronomia infrarossa? Vengono prese immagini del fondo-cielo e dell'oggetto osservato. Poi, in tempo reale, viene fatta una sottrazione dei rumori per far emergere la stella, acquisendo 10-20 immagini al secondo sia del fondo-cielo sia dell'oggetto. Le scansioni vengono sommate per ottenere un'esposizione sufficientemente chiara.
A differenza di un telescopio ottico normale, possiamo ottenere immagini pulite in pochi minuti se l'inseguimento dell'oggetto è buono: il problema è dovuto al fondo-cielo che satura il rivelatore. Gli astronomi devono fare immagini in brevissimo tempo poiché se arrivano troppi fotoni (quanti di luce) sul rivelatore, non vediamo più niente. Irait potrà funzionare sia d'estate sia d'inverno poiché il telescopio è sensibile alla luce infrarossa. Il controllo è remoto in situ: lo strumento è diretto dalla base abitata antartica Concordia dove gli scienziati lavorano alacremente. Anche nella rigida notte polare. Gli astrofisici operano a 500 mt. di distanza dallo strumento. Ovviamente non si può stare con l'occhio sull'oculare, viste le rigide polari. In teoria Irait potrebbe essere controllato in remoto dall'Italia, perché lo strumento è perfettamente predisposto.
Anche da Collurania sarebbe possibile inviare al telescopio la scheda osservativa su una particolare stella e lui saprebbe cosa fare, puntando le sue ottiche, rintracciando l'oggetto per acquisirne le immagini. Oggi non si può fare perché non ci sono collegamenti satellitari stabili. In linea di principio, con i fondi necessari, si potrebbe fare, magari anche con uno strumento di maggiori dimensioni. Ma, anche se un giorno fosse possibile renderlo pienamente autonomo, la manutenzione sarebbe sempre necessaria in situ. Irait è robotizzato. Basta dare ad Irait lo "start"! Ma l'uomo è insostituibile: servo-meccanismi polari, oscillazioni dello specchio, pompa del vuoto nella camera infrarossa, sistema criogenico per mantenere la temperatura della camera infrarossa a 4° Kelvin (-269° C) sopra lo zero assoluto all'interno del criostato, non si riparano da soli. E non si può fare da remoto. La base antartica Concordia è collegata via satellite soltanto per un'ora al giorno, quindi l'astronomia infrarossa di Irait può essere fatta solo in situ.
Pensate, oggi il solo collegamento satellitare stabile, verrebbe a costare più dell'intero progetto! Astrofisici e tecnici di Collurania partecipano a pieno titolo alla fase di montaggio di Irait. Se tutto va bene, ci vorrà ancora un anno per esaurire la fase di montaggio, dei test preliminari di controllo e per verificare il corretto funzionamento del telescopio, fino all'inizio della campagna antartica 2010-11 quando i Nostri contano di diventare pienamente operativi dal punto di vista scientifico.
La scorsa estate 2009 abbiamo avuto un Sole bianco, "dormiente" da mesi: cosa significa per gli astronomi e per la vita sulla Terra? Adesso il Sole sta ripartendo. Per gli astronomi che studiano il Sole è piuttosto scocciante una stella per così dire "bianca": in assenza di fenomeni evidenti si rimane in attesa febbrile che il ciclo di 11 anni ricominci. Una stella dormiente non spaventa gli scienziati né crea apprensione agli astrofisici. Abbiamo superato il periodo di minimo solare.
E' già successo questo ritardo. Va anche detto che le registrazioni di questi fenomeni risalgono a epoche relativamente recenti. Le macchie solari, ad esempio, sono state descritte abbastanza bene da Galileo Galilei con il suo telescopio, 400 anni fa, ma lo studio sistematico è molto più recente. Non c'è abbastanza statistica, non ci sono dati storici sufficienti a confortarci e rassicurarci. La luminosità solare, l'energia del Sole che arriva sulla Terra, è quella prodotta dalle reazioni termonucleari che, grazie a Dio, sono garantite per i prossimi cinque miliardi di anni (quanti sono gli anni del nostro luminare). Il nucleo solare gode di ottima salute come rivelano i neutrini studiati al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso dell'Infn. Piccole variazioni sulla superficie solare possono produrre variazioni nella luminosità che dipende anche dal raggio del Sole. Generalmente nelle stelle più il raggio è grande, maggiore è la luminosità indipendentemente dalla sorgente interna di energia.
Le variazioni esterne non dipendono dalle zone centrali perché non c'è interazione tra la materia solare del nucleo e quella delle zone più esterne. Il nucleo solare ha combustibile sufficiente per almeno altri 5 miliardi di anni. Ovviamente le piccole variazioni che osserviamo nel ciclo solare, sono per noi qui sulla Terra molto importanti. Anche in frazioni di percentuale l'energia assorbita dall'atmosfera terrestre può indurre fenomeni importanti sul clima e sul meteo. Ecco perché è importante monitorare anche dallo spazio l'attività solare. Che è il prodotto della concorrenza di diversi fenomeni che avvengono nella superficie solare e nelle zone immediatamente al di sotto ed al di sopra. Il motore del sole sono le reazioni termonucleari che avvengono nel nucleo: il calore e la radiazione prodotti, uscendo fuori verso gli strati più esterni della nostra stella inducono dei processi fisici. Tra cui il mescolamento (convezione), fenomeno analogo e ben visibile in una pentola che bolle dove il flusso di calore prodotto dalla fiamma elettro-magnetica genera nell'acqua un movimento dal basso verso l'alto. Analogamente il fuoco nucleare nel nucleo solare è una sorgente molto intesa di energia che induce la convezione in grado di muovere e rimescolare la materia (in prevalenza, idrogeno ed elio, gli elementi originali da cui si è formato il Sole).
La zona convettiva esterna che irradia questa energia, ha una massa piccola rispetto a quella totale solare (l'un per cento). Nonostante l'estensione, è molto meno compatta delle regioni più interne. Per cui il raggio è il 30% del totale del disco solare. All'interno questa materia viene anche ionizzata: gli atomi perdono i loro elettroni, alla base della zona convettiva ci sono due milioni e mezzo di gradi Celsius. A queste temperature l'idrogeno e l'elio sono ionizzati. Le cariche elettriche da una parte (elettroni) e i protoni nucleari dall'altra, nel mescolamento inducono delle correnti elettriche, ossia il campo elettro-magnetico descritto dalle quattro equazioni differenziali fondamentali di Maxwell. In questa zona, detta tacoclinica, dove il mescolamento è più lento, le correnti generano il campo elettro-magnetico solare che amplificato nelle zone esterne produce i fenomeni solari noti agli astrofisici come "attività solare". Tra cui le famose macchie osservate da Galilei, che sono una delle esemplificazioni più evidenti.
Un ruolo importante è giocato dalla rotazione relativamente lenta del Sole che, accoppiata al mescolamento radiale di materia, attribuisce al campo magnetico solare delle caratteristiche particolari. L'attività solare quali altri fenomeni genera? I brillamenti e le protuberanze solari che sono vere e proprie esplosioni termonucleari sulla superficie del sole: si formano così sbuffi di materia ed archi coronali. L'osservazione in tempo reale dallo spazio, grazie a telescopi orbitali come "Soho" e "Stereo", alle varie lunghezze d'onda dall'infrarosso all'ultravioletto, ci regala immagini meravigliose della nostra stella. Si parla di "spaceweather", di meteo spaziale del Sistema Solare. Quali effetti producono sulla Terra i fenomeni solari? Questi fenomeni solari non sono sempre intensi ma seguono un ciclo di circa 11 anni, la cui origine non è molto chiara. Si alternano periodi di quiete con minima attività magnetica, a mesi di Sole attivo quando i fenomeni osservati sono particolarmente intensi.
L'attività magnetica produce effetti anche sulla Terra: lo space weather è appunto legato a tali fenomeni. I fisici raccolgono i dati sulle emissioni di protoni solari che arrivano in prossimità della Terra, interagiscono con il campo magnetico terrestre, dando luogo a tutta una serie di fenomeni: disturbo delle comunicazioni, black-out, aurore polari. Sui poli le particelle cariche prodotte dall'interazione con i protoni solari, si incuneano tra le linee di forza del campo magnetico terrestre e penetrano all'interno della Terra attraverso i poli magnetici.
Con l'espansione dell'atmosfera durante il massimo solare...Tant'è che le orbite dei satelliti vanno corrette: il problema è la difficoltà della previsione di tali fenomeni; c'è un ciclo medio solare sulla cui durata e intensità non possiamo fare previsioni a priori proprio perché l'origine è legata a fenomeni caotici e casuali. Difficoltà non diversa dalle previsioni climatiche generali e dal meteo atmosferico terrestre. Solo su scale temporali brevi e con modelli matematici molto complessi, il livello di precisione è piuttosto elevato. Due anni di Sole bianco cosa significano per la Terra? Gli astrofisici hanno troppi pochi dati per capire cosa succede alla Terra. Poco il tempo, poche le osservazioni disponibili, per fare previsioni e valutazioni accurate dell'impatto sul clima e sull'estensione dei ghiacci polari. Molto difficile è attribuire al Sole questi fenomeni in atto. Sicuramente è logico ipotizzare variazioni di lungo periodo anche nel ciclo solare che, sommate a queste fasi dormienti più estese per un certo numero di cicli, probabilmente potranno avere conseguenze per la Terra.
Storicamente si associa (prima metà del XVIII Secolo) la piccola glaciazione sull'Europa a uno di questi soli dormienti. Non un solo minimo molto intenso come l'attuale, ma qualcosa di molto più importante. Anche nel nostro caso, non è una rondine che fa primavera. Se questo minimo di due anni dovesse ripetersi nel tempo, gli effetti climatici sulla Terra potrebbero essere importanti. Per ora, forse, si tratta solo una dormita particolare dovuta a fluttuazioni casuali. Il cuore del Sole non ha subito variazioni. Il comportamento del nucleo è molto stabile nell'attuale fase di sequenza principale. Le fluttuazioni minime in superficie, rispetto alla media dei dati finora osservati, raccolti e studiati, sono situazioni reversibili. Il Sole è stabile come gli antichi pensavano che fosse. Confortano gli studi sulle stelle vicine simili al nostro Sole. L'attività di tipo solare è nota in moltissime stelle, molte delle quali accompagnate da esopianeti. Negli astri classificati come magnetici, i fenomeni sono molto intensi. L'interpretazione delle osservazioni e delle misure su luminosità e spettroscopia sono influenzate dall'attività magnetica.
Uno dei metodi usati per individuare pianeti in altri sistemi solari (preconizzati da Giordano Bruno) è quello di andare a vedere il periodo e la diminuzione di luminosità di una stella quando un pianeta transita davanti al disco solare. Ne sono stati osservati finora 430 su 363 stelle. Gli astrofisici sanno che variazioni di luminosità possono essere indotte da macchie solari. E qui entra in gioco l'attività magnetica per non confondere le carte, ossia per non commettere errori sistematici nell'analisi dei dati (curve di luce) e nella ricerca di anomalie solari. Per interpretare le misure in maniera corretta, ci sono tecniche che consentono di distinguere il transito planetario dalle macchie solari. Con i telescopi spaziali come "Keplero" e "CoRot" vedremo macchie solari su altre stelle? I satelliti astro-sismologici come "Keplero" e "CoRot" sono progettati per osservare la variabilità delle stelle, la loro oscillazione radiale, non solo della superficie. Oscillazioni osservate sul nostro Sole da anni.
Questi studi hanno aperto il campo all'eliosismologia per capire com'è fatto il Sole dentro. Esattamente come succede con i terremoti sulla Terra. L'onda sismica prodotta dalla frattura della crosta terrestre, si propaga allo stesso modo, raggiunge una certa profondità, viene riflessa da uno strato interno e torna in superficie. A seconda delle caratteristiche spettrali dell'onda sismica, questa penetra nei diversi strati, "illuminandoli", fornendo agli scienziati informazioni sullo strato riflettente a diversa profondità. La stessa cosa si può fare con le stelle. Il Sole è il migliore laboratorio, il più vicino e il più facile. Ma con questi nuovi telescopi spaziali è possibile fare misure fotometriche molto precise: questa è la sismologia stellare. Fino a che distanza dal nostro Sistema Solare potrà operare il telescopio Keplero, con quale sensibilità? Dipende dalla luminosità della stella e dalle dimensioni del telescopio. Il Keplero è un sistema di telescopi interferometrici (accoppiati nello spazio) molto più grande. Altri progetti vanno in questa direzione. Poiché questi satelliti misurano variazioni di luminosità estremamente piccole (anche di una parte su 10mila dello splendore totale stellare) e sono pensati per fare sismologia stellare, si prestano molto bene per osservare piccole variazioni casuali causate anche da un transito planetario. Da qui nasce il grande interesse del pubblico e non solo della comunità scientifica. Affascina la sola idea di scoprire altri mondi.
Con questi telescopi spaziali si spera di riuscire a scoprire (cosa finora impossibile) piccoli pianeti di taglia terrestre nella fascia verde abitabile di altri sistemi solari, ossia nella zona sufficientemente distante dalla stella, in cui le condizioni utili alla vita (acqua in forma liquida, come forse su Marte e sui satelliti gioviani Europa e Callisto) possono svilupparsi. Come sapete, è stato scoperto il 430° esopianeta (spiace per gli astrologi che non lo hanno previsto!) combinando le osservazioni del telescopio spaziale francese CoRoT e del sistema ottico Harps dell'Osservatorio astronomico australe dell'Eso in Cile.
Gli astronomi hanno scoperto il primo pianeta extrasolare "normale" della Galassia, a clima temperato. Il primo gigante gassoso di taglia gioviana che può essere studiato in grande dettaglio, visto che orbita regolarmente, esattamente come il nostro Mercurio, attorno alla propria stella. Corot-9b, così è stato designato il pianeta, transita attorno al proprio luminare di classe spettrale G3 ("simile" al nostro Sole) in appena 95 giorni. Le temperature registrate (tra - 20° e + 160° Celsius) lasciano ben sperare. E' distante 1500 anni-luce dalla Terra nella costellazione del Serpente. Tuttavia dire che è stato scoperto "un nuovo mondo" è del tutto improprio, anche se nulla esclude che in quel lontano sistema solare così simile al nostro, vi possano essere altri pianeti di taglia terrestre come Pandora, magari in orbita attorno a Corot-9b e ad altri giganti gassosi come Polifemo. Saranno i più grandi telescopi terrestri, e spaziali come il "Keplero", a confermarlo (http://planetquest.jpl.nasa.gov/). Una cosa è certa: i numeri elaborati da Isaac Asimov sui sistemi solari simili al nostro in grado di ospitare pianeti in orbita regolare, magari di taglia terrestre, e sull'ammontare delle civiltà extraterrestri nella Galassia, vanno sicuramente corretti al rialzo! Così lavora la scienza che non ha fretta. La speranza è anche di trovare su Marte (ciclo dell'acqua) e su Titano (ciclo del metano) fiumi e laghi sotterranei perché si sa che la vita attecchisce anche in condizioni estreme come qui sulla Terra (abisso oceanico, laghi antartici sotterranei).
Sarebbe una scoperta rivoluzionaria per il nostro modo di pensare. Gli astrofisici credono che forme di vita aliena possano già esistere su altri pianeti simili alla Terra nella nostra Galassia e altrove? La risposta correttamente scientifica è che non si può ancora dire. Non c'è una risposta. Scienziati come Carl SaganMa è davvero così che stanno le cose? In verità siamo ignoranti su un passaggio fondamentale: sappiamo quali sono e da dove vengono i componenti basilari della vita base-carbonio nata sulla Terra, ma non sappiamo se la vita è concepibile su altre basi come il silicio, l'azoto o l'ossigeno. Limitandoci alle nostre conoscenze, da un punto di vista astrofisico, sappiamo dove si sono prodotti i costituenti essenziali della vita, quali sono le stelle che hanno prodotto i processi fisici e in quegli astri il materiale (idrogeno, elio, carbonio, azoto, etc.), ossia i mattoni necessari per costruire amminoacidi, proteine e molecole complesse (Dna, Rna).
Da una scintilla è possibile, attraverso meccanismi elettro-chimici, far evolvere l'Rna in determinate condizioni ambientali, fino a raggiungere forme complesse. Abbiamo capito come l'evoluzione teorizzata da Darwin, funziona a livello chimico micro e macroscopico, influenzata dall'ambiente. Considerando i 100 mila geni attivi nel cromosoma umano, il numero di combinazioni di possibili individui, secondo alcuni scienziati pari a 10 alla sessantesima potenza, la razza umana ha il patrimonio genetico necessario per popolare tutto l'Universo.
Cosa manca per la vita che conosciamo sulla Terra? Gli scienziati non sanno come è possibile formare da un brodo primordiale il primo protozoo ovvero semplicemente una sua molecola, un singolo amminoacido, uno dei suoi costituenti basilari per una catena a doppia elica del Dna. Ci sono stati esperimenti storici che provano la formazione di amminoacidi e strutture semplici. Ma per legare gli amminoacidi nella giusta sequenza e combinazione atta allo scoccare della scintilla della vita, così come è apparsa sulla Terra, dobbiamo capire il perché quella e non l'altra sequenza funziona ed è giusta. Gli astrofisici e i biologi molecolari devono ancora trovare la risposta. Quindi l'ignoranza su quest'informazione impedisce un calcolo statistico corretto: possiamo avere 100 miliardi di stelle nella Galassia e 100 miliardi di galassie simili alla nostra, con una possibilità su mille di trovare un pianeta simile alla Terra con la sua civiltà. Probabilità scarsa ma confortante, visto il numero di stelle, di incontrare prima o poi un altro mondo abitato.
Tuttavia, se la semplice probabilità di prendere questi amminoacidi e di legarli alla giusta maniera è prossima allo zero (badate: calcoliamo le combinazioni possibili di un set di amminoacidi giusti, dimenticandoci di come si arriva a formarli), allora scopriamo una cosa altrettanto sorprendente: la probabilità di vita nel pianeta giusto, è molto più bassa, figurarsi di vita intelligente! Ma per lo scoccare della vita sulla Terra ci deve essere stato un intervento esterno significativo, oggi scientificamente ignoto, che ha indotto in qualche modo la scintilla della prima forma di vita elementare sulla Terra. In tal caso, la probabilità di incontrare civiltà aliene non è più zero, ma prossima alla certezza assoluta!
Questo "qualcosa" in più (per gli scienziati, un catalizzatore chimico-fisico) attualmente è sconosciuto. Per cui ogni calcolo statistico è viziato ab origine. Quindi dobbiamo prima capire come e perché sono privilegiate nel nostro Universo alcune configurazioni chimiche e molecolari rispetto ad altre. E' l'affascinante tema dell'astro-biologia molecolare. Il mio sospetto è che tale catalizzatore esista e che prima o poi scoperto verrà scoperto. Tale catalizzatore miliardi di anni fa avrebbe favorito ed accelerato il processo di formazione della vita sulla Terra e su altri pianeti simili ed a noi prossimi. La teoria della panspermia interplanetaria ad opera di asteroidi e comete, quali vettori della vita, sposta solo il problema: se la prima forma di vita elementare sia venuta da fuori o si sia formata sulla Terra, non cambia molto la nostra situazione.
Gli scienziati devono scoprire il catalizzatore per capire come è scoccata la scintilla della vita. Sul nostro pianeta ci sono state le condizioni favorevoli (forse uniche nel Sistema Solare), ma non significa che il catalizzatore debba essere stato presente 3.5/4 miliardi di anni fa solo sulla Terra. Potrebbe essere benissimo diffuso nell'Universo. In tal caso avrebbe raggiunto la Terra al momento giusto. Pensate, quanta attenzione su Marte nella ricerca di forme di vita! E non su Venere e su Titano che hanno pur sempre un campo magnetico attivo. Nel caso di Venere con una massa simile a quella terrestre. Perché, si dice, su Venere c'è una densissima atmosfera infernale come confermano le interessanti misure della sonda Venus Express dove il contributo italiano è molto importante.
L'atmosfera di Venere, il suo micidiale effetto serra, il cocktail chimico letale, sembrano deporre a sfavore per lo sviluppo della vita. Mentre l'idea che su Marte in passato le condizioni potevano essere sicuramente favorevoli, ha acceso la fantasia di scienziati e scrittori. Siamo alla ricerca solo dell'acqua, perché? Non ha più senso una missione umana su Titano? Praticamente Marte oggi è sotto il nostro assedio con satelliti e sonde automatiche terrestri. Il problema della vita su Marte è molto delicato: e se poi si scoprisse che non c'è mai stata? Così lavora la scienza galileiana. Si precede per gradi, sperimentando ed osservando, pronti sempre a tornare sui propri passi. Un fatto è certo: su Marte c'era molto ossigeno miliardi di anni fa, con un'atmosfera e un campo magnetico. Il colore rosso dell'ossidazione prova l'antica presenza di ossigeno. Se noi oggi dissociassimo l'ossigeno presente nell'aria sulla Terra (18-20% del totale che respiriamo) si produrrebbero condizioni molto simili a quelle marziane. L'ossidazione è la prova-regina di un passato favorevole alla vita marziana, magari con l'ossigeno combinato, come sulla Terra, in qualcosa di molto simile alla nostra aria. Una cosa è certa: solo missioni umane di esplorazione diretta potranno confermare se la vita ha attecchito anche su Marte, Europa, Callisto e Titano, magari basata oltre che sul ciclo dell'acqua, anche sugli idrocarburi come il metano. In tal caso, assai diversa dalla nostra. La rivoluzione scientifica sul concetto di "vita" e di "mondo abitabile", sarebbe incalcolabile. I segnali non mancano.
Basta leggere sotto le righe i report dei glaciologi di tutto il mondo. Terremoti e catastrofi sono comuni nel Sistema Solare e paradossalmente generano altre possibilità per lo sviluppo della vita. Su Giove nel luglio 2009, a 15 anni esatti dall'impatto della famosa cometa Shoemaker-Levy, come osservato dal telescopio spaziale Hubble, ne è stato registrato un altro: forse una piccola cometa o un asteroide. Questi fenomeni nel Sistema Solare sono normali. Asteroidi e comete vengono influenzati dal campo gravitazionale dei pianeti più grandi e del Sole. Quelli confinati nella prima fascia di asteroidi, interagiscono a livello mareale tra Marte e Giove. Possono avvenire urti improvvisi, il moto caotico li favorisce, finendo schizzati su orbite anomale fino a impattare sui pianeti di maggiore massa che graziano così la Terra.
Tra i grossi attrattori di questi corpi minori, Giove è sicuramente il nostro più famoso "protettore", un autentico spazzino di comete ed asteroidi impazziti che altrimenti finirebbero per caderci addosso nella loro folle corsa all'interno del Sistema Solare. E che dire della più accurata mappa 3D dell'Universo, realizzata dal telescopio spaziale Hubble? Oltre a confermare la Teoria Generale della Relatività, l'espansione accelerata dell'Universo, le abbondanze di Materia ed Energia oscure (98%), il team internazionale Nasa/Esa guidato dai professori P. Simon (Università di Bonn) e T. Schrabback (Leiden Observatory), grazie alle micro lenti gravitazionali (il più potente obiettivo naturale del Cosmo, magari utile per "zoommare" su un esopianeta ET abitato!) sono riusciti per la prima volta in assoluto a sondare le profondità del Creato nel più ambizioso progetto di esplorazione e studio di 446 mila galassie. Utile a cosa? A svelare le strutture più intime dell'Universo nello spazio e nel tempo, anche se ancora non è del tutto chiaro ciò che si sta e non si sta osservando.
A ulteriore conferma che bisogna prima interrogare Colui che ha fatto il mondo, con le domande e gli esperimenti giusti, prima di contemplare la trama e l'ordito del divino disegno. hanno calcolato statisticamente il numero di civiltà aliene nella Galassia e nell'Universo. Nella peggiore delle ipotesi, sarebbero milioni.
Nicola FacciolinI