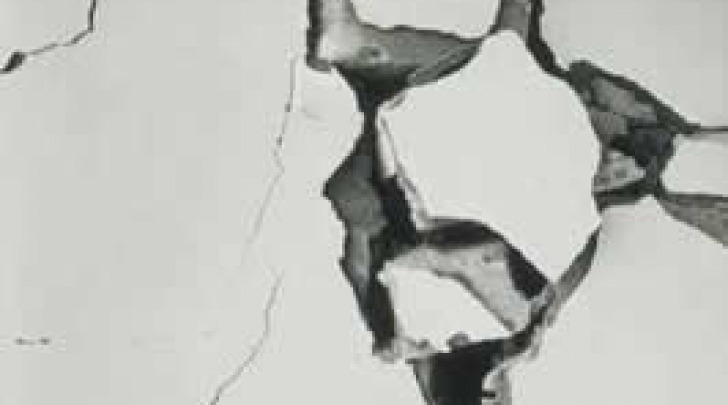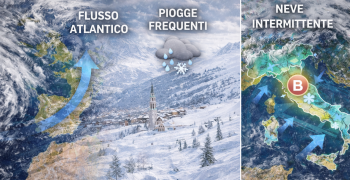Il terremoto, il crollo delle certezze, il pensiero critico
Prolusione Anno Accademico 2010
Publichiamo integralmente la prolusione per l’inaugurazione dell’ Anno Accademico 2009-2010 del professor Rocco Ronchi, ordinario di Filosofia Teoretica, Facoltà di Scienze della Formazione dell' Università dell’Aquila
IL PENSIERO COME FONDAMENTO
Colleghi universitari, personale tecnico amministrativo, Presidente della Camera dei Deputati on. Gianfranco Fini e autorità tutte, quando il Magnifico Rettore mi comunicò che era sua intenzione affidarmi il compito di tenere la prolusione per l’apertura del nuovo anno accademico, nel ringraziarlo per l’onore concessomi e per la stima mostratami, gli confessai un imbarazzo profondo, che ora rinnovo qui davanti a voi tutti.
Non è facile parlare nell’orizzonte della catastrofe che ha investito la Città e la Nostra Università.
Non è facile parlare di un nuovo anno accademico avendo ben scolpiti nella mente i volti di coloro che non saranno più con noi. Perdere degli studenti con i quali si aveva familiarità e con cui si condividevano progetti di ricerca è una cosa terribile: è capitato a me ed è capitato, purtroppo, anche a molti dei colleghi presenti in questa aula.
Penso tuttavia che la filosofia, che qui rappresento in modo certamente inadeguato, abbia il dovere di prendere la parola in circostanze come queste. Vi è una responsabilità ineludibile della filosofia, una responsabilità che è inscritta nella sua natura specifica. Tale responsabilità è tanto più forte quando più la filosofia, conformemente alla sua natura “pratica”, è vissuta eticamente come principio di una comunità possibile e, in prima istanza, come principio di una comunità educativa.
La filosofia deve infatti la propria possibilità – direi che deve la propria origine – all’insorgenza traumatica dell’evento. Uso questa espressione nel suo senso più elementare: l’evento nomina l’accadere. Non il qualcosa che accade, ma la dimensione del suo accadere, del suo aver luogo qui e ora, la sua insorgenza appunto, la quale, indipendentemente da ciò che di volta in volta accade, ha sempre qualcosa di “barbaro” e di “violento”. Anche nel linguaggio comune, quando si parla di eventi – un terremoto, ad esempio, o, più felicemente, un innamoramento o una nascita, un “lieto evento” – ciò che si mette in rilievo non è tanto, o non è soltanto il “fatto” (ciò che è accaduto) ma l’avere avuto luogo, l’essere accaduto di ciò che è di fatto accaduto. Se mi è consentito un prestito terminologico dalla linguistica, direi che con la parola evento si sottolinea non il suo contenuto fattuale, il che cosa, ma la forza illocutiva del fatto, il suo farsi, il suo prodursi, il suo che c’è.
È universalmente noto, e forse, proprio per questo è presto scaduto a ritornello pressoché insignificante, che la prassi filosofica, in quanto scienza della verità, ha il suo battesimo in quella Stimmung che i greci chiamavano thaumázein e che noi traduciamo, senza darci troppo pensiero della traduzione, con l’espressione “meraviglia”. La cosiddetta meraviglia è il corrispondente emotivo dell’evento. Ma che cosa sia questa meraviglia è forse meglio detto da altre parole, meno rassicuranti. L’evento meraviglioso è dopotutto l’insorgere di un Reale che manda in cortocircuito il nostro sapere, che ci lascia innanzitutto atterriti e senza parole. Prendo a prestito la parola Reale dall’ambito psicoanalitico, e più precisamente da quello lacaniano, dove essa nomina non la realtà ordinata e riconoscibile, ma quanto rumoreggia al fondo di quella realtà come il suo fondo oscuro e irriconoscibile, quanto ha nella crisi della realtà, nella crepa che improvvisamente si apre in essa, la condizione di possibilità del suo insorgere violento.
L’evento cosiddetto meraviglioso (e l’evento inaugurale della pratica filosofica) è allora la catastrofe istantanea di un mondo o di una realtà. Quale mondo? Quello della doxa, come lo chiamava Platone, quel mondo nel quale nulla di nuovo ci può sorprendere, perché tutto è già saputo, tutto è già detto e ordinato, un mondo famigliare che ci avvolge e che ci protegge come un liquido amniotico e nel quale “vedere” (che, ricordiamolo, è la radice della parola “teoria”) significa semplicemente riconoscere il già noto. La catastrofe costringe invece lo sguardo ad aprirsi verso qualcosa che non ha nome, qualcosa che appare, che c’è, che si dà, senza che il suo esserci sia riconducibile ad un sapere acquisito, al già noto. La catastrofe letteralmente apre gli occhi, rivela. Essa ha infatti il senso letterale della “apocalisse”, della rivelazione bruciante, del risveglio coatto dal letargo dei sensi. La catastrofe vincola ad una visione che non è libera iniziativa del soggetto, non è il libero sguardo di chi si volge al paesaggio per goderne la bellezza, ma è passione, passione subita come ogni vera passione: nella catastrofe vediamo contro la nostra volontà, contro il nostro istinto di fuga e di autoconservazione, che sarebbe quello di chiudere gli occhi e di non vedere; vediamo ma non sappiamo cosa vediamo, la sola cosa che sappiamo con certezza è che quello che vediamo non è quello che credevamo di vedere “prima” (il socratico “so di non sapere” e la cusaniana “docta ignorantia” portano ad espressione il senso spaesante di questa visione).
La teoria ha dunque a che fare con l’emergere nella catastrofe – che è sempre catastrofe di un ordine simbolico, che è sempre rovina di una tradizione, che è sempre crisi di un paradigma – del Reale. Con ciò è definito anche il compito della scienza, di ogni scienza che sia tale. La scienza tutta è attraversata da questo brivido filosofico che è, al tempo stesso, un brivido di terrore di fronte all’ignoto ed è fascinazione, desiderio e passione dell’ignoto, cioè del Reale. La scienza è perciò da sempre copernicana, è sempre scienza “rivoluzionaria” in rotta di collisione con il senso comune: lo dobbiamo sempre ricordare alla politica la quale troppo spesso, anche in buona fede, spaccia per “riforma degli studi” una normalizzazione ed una evirazione della dimensione naturalmente critica e indocile della ricerca.
Martin Heidegger, nella sua prolusione friburghese del 1929, rivolgendosi ai suoi colleghi scienziati, faceva dell’ “essere sospesi nell’angoscia” il fondamento comune di ogni sguardo teorico; lui diceva “di ogni riferimento all’ente”1, un riferimento all’ente che ciascuna scienza persegue poi nelle sue modalità particolari e in totale autonomia: l’Uno che fa da architrave ai molti, i quali altrimenti si disperderebbero nella molteplicità di saperi specialistici tra loro non comunicanti, tenuti insieme soltanto “dall’organizzazione tecnica dell’università e delle facoltà”. E la scienza è invece scienza e non tecnica se mantiene sempre vivo questo brivido. Ma lo stesso si deve dire dell’Università. Anch’essa è Uni-versità – parola pronunciando la quale bisogna far risuonare la potenza unificante di quell’Uno (Uno che la fonda e ne giustifica l’esistenza) – se tiene raccolta la molteplicità delle sue pratiche sul fondamento di questo evento inaugurale.
La teoria, dicevamo, ha a che fare con l’insorgere dell’evento. Se allora un terzo occhio non sensibile o ultrasensibile si apre per contemplare la verità, come vuole la vulgata platonica, ciò avviene al prezzo di una lacerazione sensibile, di un dolore e di un’angoscia effettivi. Edmund Husserl era coerente con tutta la tradizione filosofica quando fissava nella epoché, vale a dire in una sospensione dell’ “atteggiamento naturale” (in una messa tra parentesi delle nostre credenze ingenue sul mondo) il fondamento della prassi teorica ed il cardine del metodo fenomenologico, cioè della scienza. L’intera tradizione scientifica occidentale, come ha scritto Alfred N. Whitehead, non è nient’altro che un insieme di note a margine del testo platonico, e l’epoché è solo un altro nome per il thaumázein di cui parlava il filosofo greco. Un suo allievo, in un breve saggio del 1934, gli obiettava però che l’epoché era da intendersi in modo assai più concreto, in un modo meno astrattamente metodologico. L’epoché, affermava Jean Paul Sartre, è “un’angoscia che si impone a noi e non possiamo evitare (…) un accidente sempre possibile della nostra vita quotidiana”2: non un metodo, dunque, o non solo un metodo, ma un evento realissimo che come tutti gli “accidenti della vita quotidiana” ci colpisce dal di fuori, sorprendendoci e trovandoci sempre impreparati. Sartre scriveva queste parole a 29 anni. Era un giovane filosofo, un apprendista filosofo. Qualsiasi filosofo “maturo” che torni con la memoria ai suoi anni di apprendistato non fatica a trovare a cagione della sua vocazione una ferita inferta dal mondo, una esclusione di cui è stato vittima e di cui la teoria, alla quale si è consacrato, è il frutto. Sartre lo confessa in un passo della sua autobiografia: “ero brutto”, scrive con un candore disarmante, e volevo piacere alle donne…
Che la teoria fin dalla sua genesi sia connessa con l’insorgenza di una ferita, non significa certo che il suo ufficio sia quello di consolare o di rendere ragione. Gli “amici” di Giobbe che si radunano intorno al suo letto di dolore a filosofeggiare fanno una ben magra figura: dovrebbero soccorrerlo con i loro discorsi ma diventano, parola di Giobbe, i suoi peggiori aguzzini. Con le loro razionalizzazioni becere dove, ad esempio, il peccato consegue dalla colpa, secondo una logica impeccabile, aggiungono sadicamente nuove piaghe alle vecchie piaghe del giusto sofferente. Come denuncerà Leopardi in Amore e morte, essi rendono omaggio, “com’usa / per antica viltà l’umana gente” alla “man che flagellando si colora / nel mio sangue innocente”. Non è questo il contributo che può dare la filosofia nell’orizzonte della catastrofe. A tale proposito non c’è effettivamente molto da aggiungere alle parole con le quali Voltaire copriva di ridicolo una filosofia “edificante” ridotta a giustificazione razionale del dolore innocente (l’esempio, lo sapete tutti, era, ancora una volta, un terremoto, quello di Lisbona del 1755 nel giorno di Ognissanti!), sebbene la requisitoria di Voltaire, occorre dirlo, fosse fondata su di un fraintendimento radicale dell’autentico pensiero di Leibniz. Tuttavia è importante ribadire, soprattutto oggi, che la filosofia è scienza e non edificazione, scienza e non saggezza pratica vendibile in pillole in quelle kermesse del pensiero che sono i “festival della filosofia”. La filosofia, come ha ricordato recentemente un filosofo italiano, “ripiega in forme di saggezza quando diventa un margine del mondo”3.
Se la filosofia gode di una specificità, e forse di un primato, nell’ambito delle scienze nelle quali si articola il sapere, non è per il presunto carattere sublime del suo oggetto o per la sua generalità. Non sono dio o l’essere o il tutto a fornirle i quarti di nobiltà, ma lo sguardo che inaugura e che comunica di fatto a tutte le scienze particolari, le quali finché sono scienze e non tecniche, restano perciò intimamente filosofiche (e lo sono anche e direi soprattutto quando vogliono liberare le loro concrete pratiche dai residui “metafisici” o “teologici” in esse presenti). La filosofia è, da questo punto di vista, veramente il sapere comune a tutti coloro che partecipano all’impresa scientifica.
Ed è la radice di ogni comunità educativa, dal momento che l’educazione deve essere in prima istanza, quale che siano i suoi contenuti, una educazione alla lucidità dello sguardo cioè alla critica. Educare significa e-ducere, trarre, condurre fuori, fuori dalla caverna, porre nell’aperto, al cospetto del sole abbagliante della verità: ancora una volta abbiamo a che fare con occhi che si devono aprire e che faticano ad aprirsi, occhi che, una volta dischiusi, vedono e al tempo stesso non vedono, perché hanno palpebre appesantite dall’abitudine alle tenebre, ancora una volta abbiamo a che fare con una violenza imposta che diviene però maieutica: nell’e-ducazione ha luogo un incontro-scontro con il Reale, un incontro-scontro che è però paideutico, che è la paideía.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale le “scienze della formazione” hanno ritenuto di doversi liberare dal giogo filosofico a loro imposto dalla cultura neo-idealista, ampiamente screditata per il suo rapporto con il regime fascista. Hanno teso, con molte buone ragioni, all’autonomia epistemologica, ma con l’acqua sporca hanno gettato anche il bambino. Emancipatesi dalla filosofia si sono incamminate sulla via di una tecnicizzazione sfrenata rimanendo, alla fine, nude alla meta. Perché una formazione che non è filosofica nella sua radice non è più scienza, così come non è matematica una mera competenza tecnica nella manipolazione dei segni che non sia, al tempo stesso, intuizione e creazione del campo problematico nel quale soltanto si genera una soluzione (che non sia, cioè, filosofia)
Mi sia permesso, a questo proposito, aprire una brevissima parentesi. Credo che, se si vuole davvero fare i conti con il futuro delle scienze della formazione, la pratica recante il nome di Giovanni Gentile vada riaperta “laicamente”, nella misura in cui quel nome pone un problema inaggirabile concernente la fondazione speculativa della didattica, un problema che non è mai stato veramente risolto, tantomeno dalla riforma che porta il suo nome, indubbiamente classista e, per alcuni aspetti, odiosamente fascista, ma che tuttavia Gentile ha il merito di aver posto con grande chiarezza. Chiusa parentesi.
Porre perciò la filosofia a fondamento non significa privilegiare una disciplina particolare, la quale, anzi, come disciplina storica degli studi filosofici è forse destinata ad un ruolo sempre più marginale nell’attuale ordinamento degli studi universitari (va da sé che abbiamo più necessità di bravi ingegneri che di bravi filosofi analitici del linguaggio). Significa piuttosto rivendicare il primato della teoria, vale a dire di quella contemplazione alla quale siamo costretti, in modo anche doloroso, quando il Reale si manifesta. I filosofi neoplatonici, quelli pagani come quelli cristiani, hanno battezzato questo rivolgimento dello sguardo con una espressione felice: epistrophé (o, per dirla alla latina, conversio). La filosofia, generata dalla katastrophé, si realizza allora come epistrophé dello sguardo: conversione dalla distrazione, dalla diversio, dal divertissement, dalla dispersione nel mondo della doxa.
La filosofia, in quanto epistrophé, riattiva quel senso fungente che si è sedimentato, fino a diventare impercettibile, al di sotto delle nostre pratiche abituali di insegnanti, di scienziati specializzati, di storici della filosofia. Essa non corregge o completa le scienze particolari, non pretende ridicolmente di entrare nel merito della loro operatività o di accrescere la massa delle conoscùenze positive, piuttosto, come ha detto una volta Simone Weil, in ciò che si presenta come una “coesione di segni” anonima e meccanica regolata dal solo “criterio dell’efficacia” ritrova “l’attività metodica del pensiero” fondata sul criterio della verità. Tale, mi pare, è il significato di quell’aggettivo, “teoretica”, che accompagna, nella definizione burocratica della mia classe di concorso, la parola “filosofia” e che spesso è oggetto di una perplessa interrogazione, non priva di un qualche sarcasmo.
Nel lemma “catastrofe” è dunque detta questa apparizione del vero che ci riguarda in quanto scienziati. Ecco perché ho aperto la mia prolusione affermando che la filosofia, in quanto scienza della verità, ha una responsabilità particolare in un contesto drammatico come quello che stiamo vivendo. Una catastrofe reale ha avuto luogo. Noi tutti siamo chiamati al difficile lavoro della ricostruzione. Dobbiamo ricominciare. Un nuovo anno accademico ci attende. Non possiamo più fare affidamento sui meccanismi ben oliati della routine accademica. Siamo costretti a porre e a porci di nuovo la domanda essenziale, quella che chiede quale sia il senso del nostro essere qui e ora davanti a degli studenti che hanno accettato la sfida della continuità insieme a noi e forse con maggiore coraggio di noi (se si considerano le enormi difficoltà materiali cui devono fare fronte). Chi siamo noi, insomma, in quanto “professori”, in quanto cioè “compromessi” con la verità, al servizio di una ricerca in comune della verità?
Il professore, credo, non è riducibile né alla figura dell’esperto né si solleva alla dimensione, per altro assai ambigua, del saggio. Indubbiamente è titolare di una competenza e la rivendica orgogliosamente, ma non si risolve nella dimensione neutrale del “tecnico”. D’altronde non ha nemmeno la pretesa né il diritto di porsi come un auratico “maestro di verità”, non è titolare di una sapienza che concerne il “perché” ultimo dell’esistenza. Paradossalmente la società dello spettacolo, nella quale siamo immersi fino all’obbrobrio, non riesce ad immaginare altre funzioni per l’intelligenza scientifica: o è tecnica al servizio della macchina della produzione o è sapienza concernente “valori trascendenti”. In entrambi i casi manca e sfigura la specificità del nostro lavoro. Per questo, forse, la società dello spettacolo non è in grado di pensare positivamente il ruolo dell’università e ora la degrada a parte dell’ingranaggio economico – ed è la tendenza dominante – oppure la fantastica come luogo separato dalla società nella quale si coltivano anime belle destinandole ad un futuro di precoce e brutale precarietà. Sostanzialmente la distinzione tra facoltà tecnico-scientifiche e facoltà umanistiche ricalca questa visione, sebbene anche queste ultime, per ragioni di elementare sopravvivenza, siano ormai orientate ad una ristrutturazione integralmente tecnica dei loro curricula.
Ma la specificità del nostro comune lavoro è, credo, un’altra. Essa concerne il pensiero, anzi il pensare, l’atto del pensare, inteso come fundamentum inconcussum, come l’Uno immobile intorno al quale ruota, in modo tolemaico, il sistema dei saperi particolari: l’unum dell’universitas studiorum. Tale atto è disinteressato non perché avulso dalla macchina sociale, ma perché il suo interesse esclusivo è il suo stesso esercizio che costituisce, come un’antichissima tradizione attesta, il fine di ogni attività umana, la prãxis, la pratica teoretica, nella quale si risolve il bíos qualificato dell’uomo. Definire libero un siffatto pensare è poi un pleonasmo, perché il suo stesso evento coincide con la libertà, con il farsi fenomeno della libertà. Un pensiero non libero sarebbe semplicemente un non-pensiero, sarebbe una macchina che funziona. Calcolo e non pensiero.
Ancora Edmund Husserl, in un manoscritto risalente agli ultimi anni della sua vita (siamo nel 1934), quando la catastrofe del fascismo si era ormai abbattuta sull’Europa, affermava che c’è qualcosa che per sua intrinseca natura resiste anche al più terribile dei terremoti. Die Urarche Erde bewegt sich nicht, cioè “L’arca originaria Terra non si muove”: questo era il titolo enigmatico con il quale Husserl aveva contrassegnato l’involucro che lo conteneva nell’archivio. C’è una Terra, scrive il filosofo tedesco, che “non si muove né è in riposo (perché) è solo in riferimento a lei che quiete e moto hanno un senso”4. Di che miracolosa Terra sta qui parlando Husserl? Certamente non si tratta di contenuti, di valori, di saldi principi metafisici o di teorie scientifiche, perché tutto ciò che il pensiero ha pensato e ha posto come vero è stato o sarà trascinato dal pensiero stesso nel vortice della sua dissoluzione. Uno dei sensi dell’attività scientifica, al cui servizio si pone la comunità dei ricercatori, è infatti proprio la dissoluzione sistematica e spietata degli idoli della conoscenza. Niente resiste alla critica. La falsificazione è il demone ed il collante della comunità scientifica. “Non saprei oggi concedere troppo alla mia diffidenza”, scrive Cartesio Queste parole, tratte dalla prima delle sue Meditazioni metafisiche, andrebbero scolpite sulla porta di ingresso di una qualsiasi università occidentale. La fede incondizionata nella verità caratteristica della scienza occidentale si manifesta proprio nella modalità del sospetto universale. Un “buon europeo”, direbbe Nietzsche, lo si riconosce proprio da questo tratto faustiano: non dismette mai un tale atteggiamento di esasperata criticità, anzi lo approfondisce, lo rinnova, lo cova, proprio come certi mistici fanno con le loro piaghe, segni inequivocabili di santità. Arriva perfino a dubitare della verità stessa, del suo “valore assoluto”, come è capitato a Nietzsche stesso che chiamò “morte di Dio”, venir meno di tutti i valori trascendenti, il punto iperbolico di diffidenza cui non può non pervenire una scienza ostinatamente fedele al suo solo motivo ispiratore.
Ma se non è un contenuto, se non è un pensato, di che cosa è fatta allora questa Terra immobile e “salva” che viene prima di ogni distinzione tra quiete e riposo? La risposta è contenuta già nella domanda. È il pensiero, infatti, che nega incessantemente il valore di verità, la trascendenza dei propri contenuti, è lui che li mette in questione rovinandone la stabilità e facendosi nemico di ogni ordine costituito. Lui e noi, in quanto scienziati devoti della verità e avversari implacabili dell’idolatria. È il pensiero in quanto attività, in quanto prãxis, in quanto pura forma, a fungere da Terra ultrastabile e non il pensiero in quanto dottrina, sapere, ideologia.
Con ciò ci imbattiamo in un Assoluto che resiste anticipatamente ad ogni critica perché l’esercizio dissolvente della critica già lo presuppone operante. L’Assoluto è finalmente “presso di noi” nella forma di un pensare che è salvo da ogni sommovimento tellurico perché è lui il cuore immobile di ogni terremoto. Il libero pensiero è quindi il fondamento che non crolla e sul quale soltanto è possibile sempre ricominciare a costruire con la certezza che ciò che avrà le radici in esso avrà radici nell’eterno. Così ragionava un italiano anomalo, Giacomo Leopardi, nella Ginestra o il fiore del deserto. Nei “lumi” del pensiero critico, nei lumi della filosofia che dissolve, relativizzandola, ogni “superba fola”, egli infatti poneva l“altra radice” dell’ “onesto” e del “retto conversare cittadino”: “il pensiero, / – cito – solo per cui risorgemmo / dalla barbarie in parte, e per cui solo / si cresce in civiltà”.
L’Università è stata negli ultimi anni oggetto di campagne infamanti da parte dei media. Con un accanimento inusitato, che, data la miserevole situazione del paese, avrebbe forse meritato ben altri bersagli, è stata fatta oggetto di denunce di ogni genere: malaffare, corruzione, nepotismo ecc. Ci sono fondati motivi alla base di tali accuse. È nostro dovere averli ben presente e cercare in ogni modo di correggerli. Tuttavia, forte è la sensazione che il bersaglio vero di questi attacchi, un bersaglio innominabile come tale, sia un altro, sia il fondamento comune sul quale l’istituzione Università non può non riposare: sia il libero pensiero. La difesa dell’Università e la difesa del libero pensiero sono la stessa cosa.
La difesa e la promozione del libero pensiero sono però anche molto di più. Permettetemi, in conclusione, di citare un passo di Simone Weil, tratto dalle sue Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, anch’esso composto nel 1934. Scriveva la filosofa francese: “Si dice spesso che la forza è impotente a soggiogare il pensiero; ma perché sia vero, è necessario che vi sia pensiero. Là dove le opinioni irragionevoli prendono il posto delle idee, la forza può tutto. È per esempio molto ingiusto dire che il fascismo annienta il pensiero libero; in realtà è l’assenza di pensiero libero che rende possibile l’imposizione di dottrine ufficiali del tutto sprovviste di significato”5.
La nostra chance per il futuro è allora quella di ricostruire la nostra università sul solo fondamento che sappiamo essere anticipatamente salvo da ogni sommovimento e che sappiamo condiviso da tutti coloro che partecipano dell’impresa scientifica: il libero pensiero ed il suo implacabile rigore critico. La filosofia.
Onoreremo così la memoria degli studenti che non sono più con noi.''